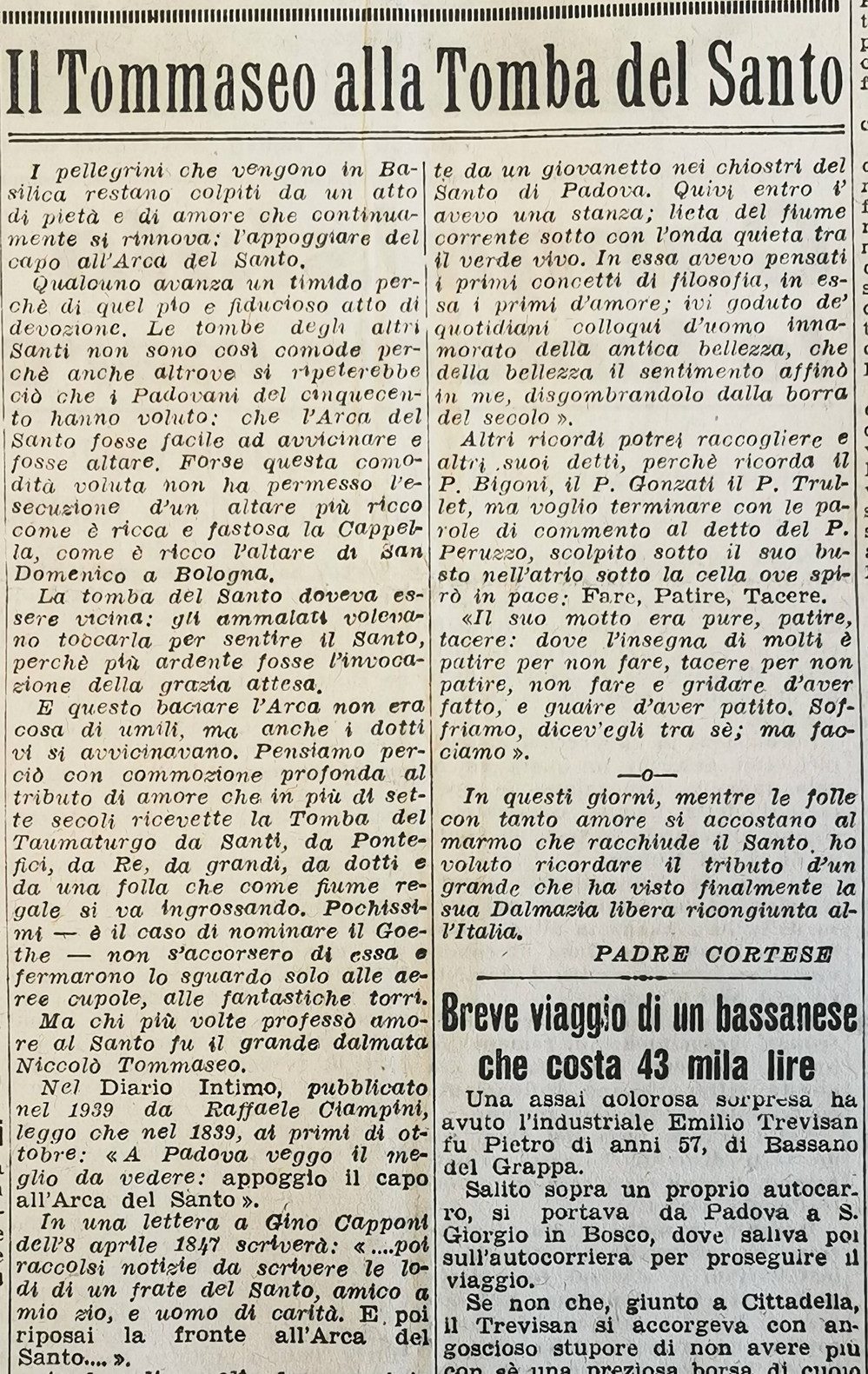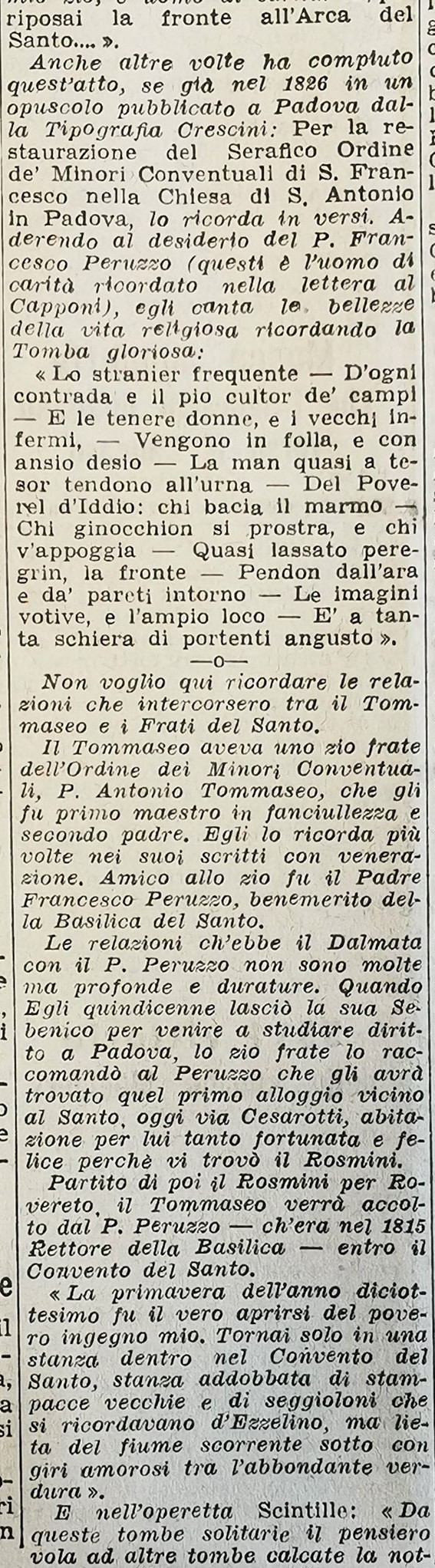Un istriano-dalmata come di fatto fu il Padre Placido Cortese, per aver avuto i natali nell’isola di Cherso, non poteva non nutrire simpatia per un grande dalmata, insigne linguista e patriota italiano, devoto pellegrino alla tomba del Santo di Padova: Niccolò Tommaseo, al quale dedicò questo scritto, pubblicato dal quotidiano patavino.
I pellegrini che vengono in Basilica restano colpiti da un atto di pietà e di amore che continuamente si rinnova: l’appoggiare del capo all’Arca del Santo.
Qualcuno avanza un timido perché di quel pio e fiducioso atto di devozione. Le tombe degli altri Santi non sono così comode perché anche altrove si ripeterebbe ciò che i Padovani del cinquecento hanno voluto: che l’Arca del Santo fosse facile ad avvicinare e fosse altare. Forse questa comodità voluta non ha permesso l’esecuzione d’un altare più ricco come è ricca e fastosa la Cappella, come è ricco l’altare di San Domenico a Bologna.
La tomba del Santo doveva essere vicina: gli ammalati volevano toccarla per sentire il Santo, perché più ardente fosse l’invocazione della grazia attesa.
E questo baciare l’Arca non era cosa di umili, ma anche i dotti vi si avvicinavano. Pensiamo perciò con commozione profonda al tributo di amore che in più di sette secoli ricevette la Tomba del Taumaturgo da Santi, da Pontefici, da Re, da grandi, da dotti e da una folla che come fiume regale si va ingrossando. Pochissimi – è il caso di nominare il Goethe – non s’accorsero di essa e fermarono lo sguardo solo alle aeree cupole, alle fantastiche torri.
Ma chi più volte professò amore al Santo fu il grande dalmata Niccolò Tommaseo.
Nel «Diario Intimo», pubblicato nel 1939 da Raffaele Ciampini, leggo che nel 1839, ai primi di ottobre: “A Padova veggo il meglio da vedere: appoggio il capo all’Arca del Santo”.
In una lettera a Gino Capponi dell’8 aprile 1847 scriverà: “…poi raccolsi notizie da scrivere le lodi di un frate del Santo, amico a mio zio, e uomo di carità. E poi riposai la fronte all’Arca del Santo…”.
Anche altre volte ha compiuto quest’atto, se già nel 1826 in un opuscolo pubblicato a Padova dalla Tipografia Crescini: «Per la restaurazione del Serafico Ordine de’ Minori Conventuali di S. Francesco nella Chiesa di S. Antonio in Padova», lo ricorda in versi. Aderendo al desiderio del P. Francesco Peruzzo (questi è l’uomo di carità ricordato nella lettera al Capponi), egli canta le bellezze della vita religiosa ricordando la Tomba gloriosa:
“Lo stranier frequente – D’ogni contrada e il pio cultor de’ campi – E le donne, e i vecchi infermi – Vengono in folla, e con ansio desio – La man quasi a tesor tendono all’urna – Del Poverel d’Iddio: chi bacia il marmo – Chi ginocchion si prostra, e chi v’appoggia – Quasi lassato peregrin, la fronte – Pendon dall’ara e da’ pareti intorno – Le imagini votive, e l’ampio loco – È a tanta schiera di portenti angusto”.
Non voglio qui ricordare le relazioni che intercorsero tra il Tommaseo e i Frati del Santo.
Il Tommaseo aveva uno zio frate dell’Ordine dei Minori Conventuali, P. Antonio Tommaseo, che gli fu primo maestro in fanciullezza e secondo padre. Egli lo ricorda più volte nei suoi scritti con venerazione. Amico allo zio fu il Padre Francesco Peruzzo, benemerito della Basilica del Santo.
Le relazioni ch’ebbe il Dalmata con il P. Peruzzo non sono molte ma profonde e durature. Quando Egli quindicenne lasciò la sua Sebenico per venire a studiare diritto a Padova, lo zio frate lo raccomandò al Peruzzo che gli avrà trovato quel primo alloggio vicino al Santo, oggi via Cesarotti, abitazione per lui tanto fortunata e felice perché vi trovò il Rosmini [si tratta di Antonio Rosmini (1797-1855), sacerdote roveretano e illustre filosofo, fondatore dell’Istituto della Carità, beatificato da Benedetto XVI nel 2007; cfr. rosmini.it].
Partito di poi il Rosmini per Rovereto, il Tommaseo verrà accolto dal P. Peruzzo – ch’era nel 1815 Rettore della Basilica – entro il Convento del Santo.
“La primavera dell’anno diciottesimo fu il vero aprirsi del povero ingegno mio. Tornai solo in una stanza dentro nel Convento del Santo, stanza addobbata di stampacce vecchie e di seggioloni che si ricordavano d’Ezzelino, ma lieta del fiume scorrente sotto con giri amorosi tra l’abbondante verdura”.
E nell’operetta «Scintille»: “Da queste tombe solitarie il pensiero vola ad altre tombe calcate la notte da un giovanetto nei chiostri del Santo di Padova. Quivi entro i’avevo una stanza; lieta del fiume corrente sotto l’onda quieta tra il verde vivo. In essa avevo pensati i primi concetti di filosofia, in essa i primi d’amore; ivi goduto de’ quotidiani colloqui d’uomo innamorato della antica bellezza, che della bellezza il sentimento affinò in me, disgombrandolo dalla borra del secolo”.

Padova – Convento del Santo – Biblioteca
Il busto di P. Francesco Peruzzo († 1847) con il suo motto: “Fare – Patire – Tacere”
Altri ricordi potrei raccogliere e altri suoi detti, perché ricorda il P. Bigoni, il P. Gonzati e il P. Trullet, ma voglio terminare con le parole di commento al detto del P. Peruzzo, scolpito sotto il suo busto nell’atrio sotto la cella [ora nella Biblioteca del convento] ove spirò in pace: «Fare, Patire, Tacere».
“Il suo motto era pure fare, patire, tacere: dove l’insegna di molti è patire per non fare, tacere per non patire, non fare e gridare d’aver fatto, e guaire d’aver patito. Soffriamo, dicev’egli tra sé; ma facciamo”.
In questi giorni, mentre le folle con tanto amore si accostano al marmo che racchiude il Santo, ho voluto ricordare il tributo d’un grande che ha visto finalmente la sua Dalmazia libera ricongiunta all’Italia.
PADRE CORTESE