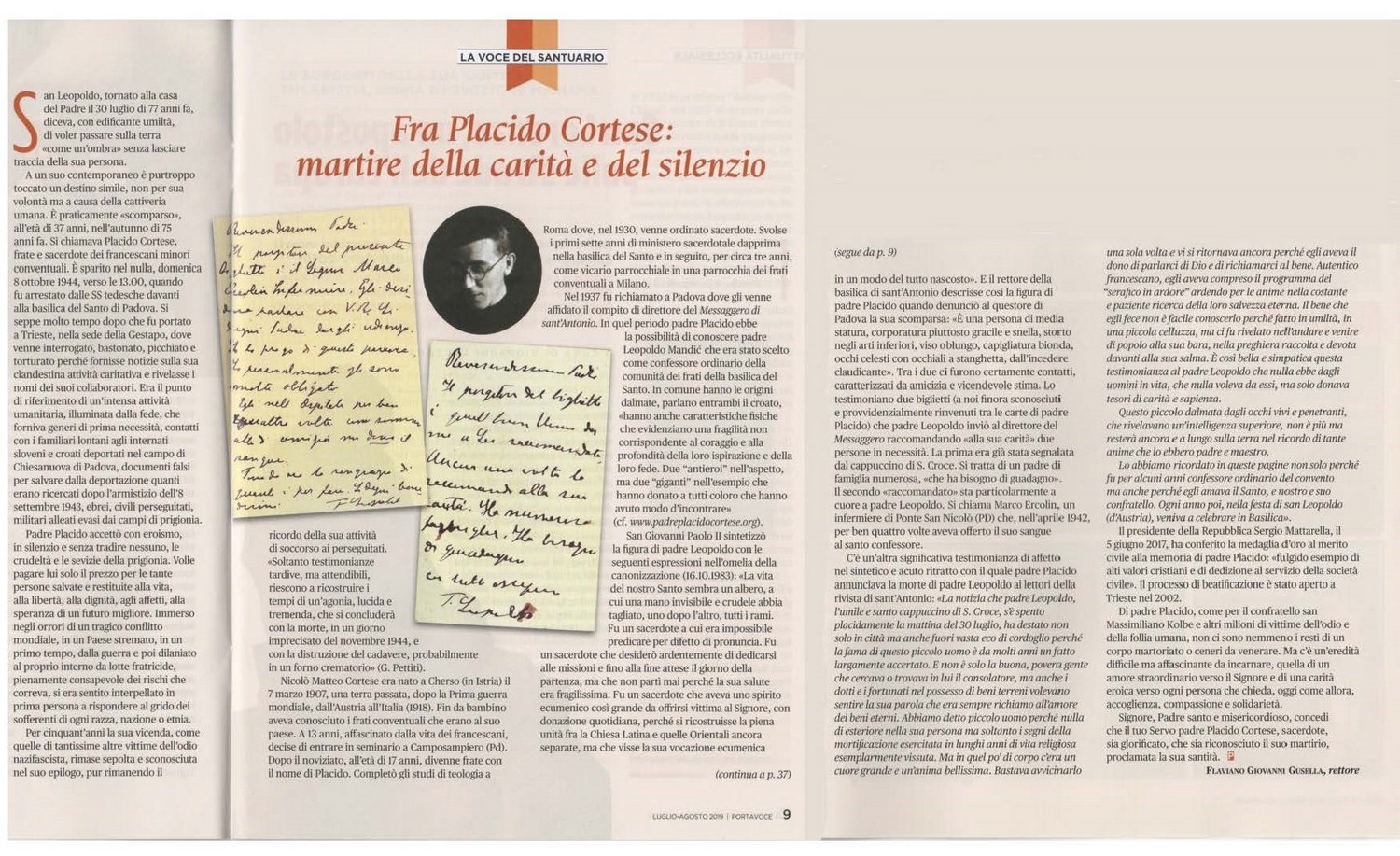Il rettore del santuario padovano di san Leopoldo Mandić ha voluto ricordare l’anniversario della morte del santo cappuccino (+ 30 luglio 1942), rievocando la fraterna e reciproca stima tra Padre Leopoldo, “piccolo dalmata dagli occhi vivi e penetranti” e il Servo di Dio P. Placido Cortese, suo penitente, che ha lasciato “un’eredità difficile ma affascinante da incarnare, quella di un amore straordinario verso il Signore e di una carità eroica verso ogni persona, che chieda, oggi come allora, accoglienza, compassione e solidarietà”.
San Leopoldo, tornato alla casa del Padre il 30 luglio di 77 anni fa, diceva, con edificante umiltà, di voler passare sulla terra «come un’ombra» senza lasciare traccia della sua persona.
A un suo contemporaneo è purtroppo toccato un destino simile, non per sua volontà ma a causa della cattiveria umana. È praticamente «scomparso», all’età di 37 anni, nell’autunno di 75 anni fa.
Si chiamava Placido Cortese, frate e sacerdote dei francescani minori conventuali.
È sparito nel nulla, domenica 8 ottobre 1944, verso le 13.00, quando fu arrestato dalle SS tedesche davanti alla basilica del Santo di Padova. Si seppe molto tempo dopo che fu portato a Trieste, nella sede della Gestapo, dove venne interrogato, bastonato, picchiato e torturato perché fornisse notizie sulla sua clandestina attività caritativa e rivelasse i nomi dei suoi collaboratori. Era il punto di riferimento di un’intensa attività umanitaria, illuminata dalla fede, che forniva generi di prima necessità, contatti con i familiari lontani agli internati sloveni e croati deportati nel campo di Chiesanuova di Padova, documenti falsi per salvare dalla deportazione quanti erano ricercati dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, ebrei, civili perseguitati, militari alleati evasi dai campi di prigionia.
Padre Placido accettò con eroismo, in silenzio e senza tradire nessuno, le crudeltà e le sevizie della prigionia. Volle pagare lui solo il prezzo per le tante persone salvate e restituite alla vita, alla libertà, alla dignità, agli affetti, alla speranza di un futuro migliore. Immerso negli orrori di un tragico conflitto mondiale, in un Paese stremato, in un primo tempo, dalla guerra e poi dilaniato al proprio interno da lotte fratricide, pienamente consapevole dei rischi che correva, si era sentito interpellato in prima persona a rispondere al grido dei sofferenti di ogni razza, nazione o etnia.
Per cinquant’anni la sua vicenda, come quelle di tantissime altre vittime dell’odio nazifascista, rimase sepolta e sconosciuta nel suo epilogo, pur rimanendo il ricordo della sua attività di soccorso ai perseguitati.
«Soltanto testimonianze tardive, ma attendibili, riescono a ricostruire i tempi di un’agonia, lucida e tremenda, che si concluderà con la morte, in un giorno imprecisato del novembre 1944, e con la distruzione del cadavere, probabilmente in un forno crematorio» (G. Pettiti).
Nicolò Matteo Cortese era nato a Cherso (in Istria) il 7 marzo 1907, una terra passata, dopo la prima guerra mondiale, dall’Austria all’Italia (1918). Fin da bambino aveva conosciuto i frati conventuali che erano al suo paese. A 13 anni, affascinato dalla vita dei francescani, decise di entrare in seminario a Camposampiero (Pd). Dopo il noviziato, all’età di 17 anni, divenne frate con il nome di Placido. Completò gli studi di teologia a Roma dove nel 1930 venne ordinato sacerdote. Svolse i primi sette anni di ministero sacerdotale dapprima nella basilica del Santo e in seguito, per circa tre anni, come vicario parrocchiale in una parrocchia dei frati conventuali a Milano. Nel 1937 fu richiamato a Padova dove gli venne affidato il compito di direttore del Messaggero di S. Antonio. In quel periodo padre Placido ebbe la possibilità di conoscere padre Leopoldo Mandić che era stato scelto come confessore ordinario della comunità dei frati della basilica del Santo. In comune hanno le origini dalmate, parlano entrambi il croato, «hanno anche caratteristiche fisiche che evidenziano una fragilità non corrispondente al coraggio e alla profondità della loro ispirazione e della loro fede. Due “antieroi” nell’aspetto, ma due “giganti” nell’esempio che hanno donato a tutti coloro che hanno avuto modo d’incontrare» (cf. www.placidocortese.org). San Giovanni Paolo II sintetizzò la figura padre Leopoldo con le seguenti espressioni nell’omelia della canonizzazione (16.10.1983): «La vita del nostro Santo sembra un albero, a cui una mano invisibile e crudele abbia tagliato, uno dopo l’altro, tutti i rami. Fu un sacerdote a cui era impossibile predicare per difetto di pronuncia. Fu un sacerdote che desiderò ardentemente di dedicarsi alle missioni e fino alla fine attese il giorno della partenza, ma che non partì mai perché la sua salute era fragilissima. Fu un sacerdote che aveva uno spirito ecumenico così grande da offrirsi vittima al Signore, con donazione quotidiana, perché si ricostruisse la piena unità fra la Chiesa Latina e quelle Orientali ancora separate, ma che visse la sua vocazione ecumenica in un modo del tutto nascosto».